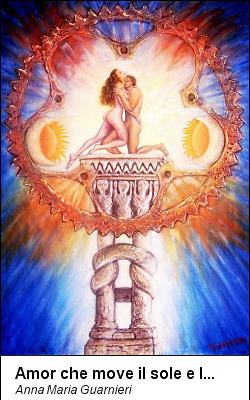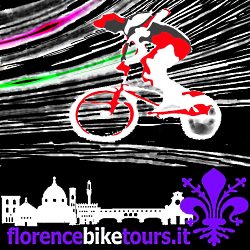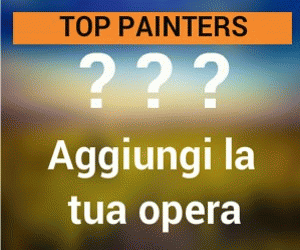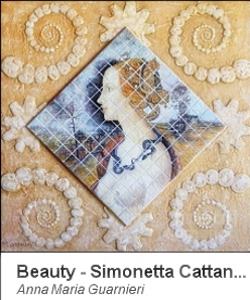Pitture e artisti |

Venezia la città d'arte dei Dogi
Venezia la città d'arte dei Dogi, con la sua storia e i suoi luoghi d'arte, sempre in mostra permanente
![]() Venezia in video
Venezia in video
![]() Mappa Venezia
Mappa Venezia
![]() Visita virtuale con Google Maps
Visita virtuale con Google Maps
Venezia - STORIA
La data convenzionale della nascita di Venezia è il 25 marzo 421, quando
avvennero i primi stanziamenti delle popolazioni del Veneto continentale che
cercavano  rifugio
nella zone acquitrinose. Questi gruppi costruirono villaggi su zattere fatte di
pali di legno conficcati nella terra sotto l'acqua, gettando le fondamenta per i
palazzi galleggianti di oggi. Il maggiore insediamento si concentrò su
Rivo Alto (oggi Rialto, ovvero la parte più alta della laguna), e Venezia
lentamente si sviluppò fino a diventare una repubblica. Diede adesione formale
all'Impero Bizantino e il primo della serie dei 118 dogi di Venezia venne eletto
nel 697.
rifugio
nella zone acquitrinose. Questi gruppi costruirono villaggi su zattere fatte di
pali di legno conficcati nella terra sotto l'acqua, gettando le fondamenta per i
palazzi galleggianti di oggi. Il maggiore insediamento si concentrò su
Rivo Alto (oggi Rialto, ovvero la parte più alta della laguna), e Venezia
lentamente si sviluppò fino a diventare una repubblica. Diede adesione formale
all'Impero Bizantino e il primo della serie dei 118 dogi di Venezia venne eletto
nel 697.
Il nome di Venezia venne definitivamente collegato a quello di San
Marco quando le spoglie dell'apostolo vennero trafugate da Alessandria d'Egitto
nell’828 e portate qui perché venissero custodite nella Basilica di San Marco,
costruita appositamente e consacrata nel 1094. Nel 1095 la Repubblica
Serenissima fornì le navi a papa Urbano II per condurre la prima crociata, che
degenerò nel saccheggio e nella devastazione dell'Impero Bizantino e di
Gerusalemme.
La quarta crociata, del 1202, vide i Veneziani depredare e
infine conquistare Costantinopoli. Fecero parte del bottino i quattro cavalli di
bronzo, la pala d'altare conosciuta come Pala d'Oro e una serie di statue di
marmo che adornano la Basilica di San Marco. A quel tempo Venezia controllava un
fiorente e grandioso impero commerciale, con il vessillo di San Marco che
sventolava su gran parte del Mediterraneo orientale. Le ricchezze che la città
accumulava ricadevano sotto il controllo del Gran Consiglio, costituito dai
membri delle famiglie più ricche e potenti.
Dopo una serie di battaglie e di trattati di pace inconcludenti con la rivale
repubblica marinara di Genova (che si conclusero con la vittoria definitiva di
Venezia nella battaglia di Chioggia del 1380) la città lagunare rivolse le sue
attenzioni verso la terraferma, acquistando autonomia e alleati per sostenere la
propria popolazione, che era stata decimata dalla peste nel 1348.
I commerci
continuarono a fiorire, ma la presa di Costantinopoli da parte dei Turchi nel
1453 segnò l'inizio della fine del dominio veneziano. Nel nuovo ordine mondiale
fatto di stati nazionali e di imperi globali, la piccola Venezia non fu in grado
di tenere il passo. I Turchi si fecero rapidamente strada nell'impero
mediterraneo della Serenissima, prendendo Cipro nel 1570 e Creta nel 1669.
All'interno cresceva frattanto la corruzione e Venezia non aveva la volontà e la
capacità di equipaggiare né una flotta né un esercito abbastanza grandi da
fronteggiare quelle dei suoi nemici. La peste colpì ripetute volte, spazzando
via fino a un terzo della popolazione, e un gran numero di tesori d'arte
andarono perduti nel rogo che distrusse il palazzo del doge. Fu in questo
contesto che si inserì l'arrivo di Napoleone nel 1797 e il definitivo
ridimensionamento della città assoggettata all'Austria. I moti che portarono
all'unità d'Italia si diffusero velocemente in Veneto e Venezia venne annessa al
Regno d'Italia nel 1866. La città fu un pullulare di attività negli ultimi due
decenni del XIX secolo: aumentò il traffico marittimo e l'industria ebbe nuovo
impulso; venne costruito un ponte ferroviario per collegare Venezia alla
terraferma, cancellando per sempre lo status di isola della città lagunare; i
canali vennero allargati e resi più profondi; nel centro cittadino vennero
predisposte zone pedonali; e il turismo cominciò a decollare. Sotto Mussolini
venne costruito un ponte stradale a fianco di quello ferroviario.
Il sestiere SAN MARCO
 Cuore
della città di Venezia, il sestiere San Marco si sviluppò intorno a Piazza San
Marco che anticamente si chiamava «Morso», forse perché il suo terreno era
più tenace e duro del circostante, e «Brolo» perché era erbosa e cinta di
alberi. E’ stata il centro della vita civile e religiosa della città.
Cuore
della città di Venezia, il sestiere San Marco si sviluppò intorno a Piazza San
Marco che anticamente si chiamava «Morso», forse perché il suo terreno era
più tenace e duro del circostante, e «Brolo» perché era erbosa e cinta di
alberi. E’ stata il centro della vita civile e religiosa della città.
A San
Marco il Doge era consacrato e acclamato e alla sua morte il corteo funebre una
volta raggiunta Piazza, ne sollevava la salma per nove volte  in
segno di estremo saluto. I “capitani da mar” ossia gli ammiragli della
Serenissima prima della partenza per le loro storiche imprese ricevevano le
insegne del comando in Piazza San Marco, sia in tempo di pace che in tempo di
guerra.
in
segno di estremo saluto. I “capitani da mar” ossia gli ammiragli della
Serenissima prima della partenza per le loro storiche imprese ricevevano le
insegne del comando in Piazza San Marco, sia in tempo di pace che in tempo di
guerra.
Anche grazie a Napoleone
Piazza San Marco è conosciuta come “il più
bel salotto d'Europa“, e i visitatori, come i piccioni, accorrono qui da secoli
per misurarne passo passo ogni singolo metro quadrato, La piazza San Marco -
l'unica a Venezia che porta il nome di piazza, tutte le altre si chiamano
"campi" - è per il suo eccezionale decoro definita la più bella piazza del
mondo.
Per quanto delineatesi nel Medioevo, avendo assunto l'attuale
estensione nel secolo XII, ha schietto carattere rinascimentale. Tutta chiusa,
sì da somigliare piuttosto a un immenso salone marmoreo a cielo aperto, si
allunga trapezoidale davanti alla Basilica di San Marco che, con la sua espansa
facciata rutilante di mosaici e di gotiche fioriture, le fa da miracoloso
fondale ne è anche prospetticamente l'assoluta protagonista.
 La
Basilica di San Marco è uno dei più spettacolari luoghi di culto del
mondo, simbolo dell'antica potenza marittima e commerciale della Repubblica
veneziana. Decorata con un incredibile numero di tesori giunti qui come bottino
di guerra, sormontata da cinque cupole a bulbo, sul modello della Chiesa dei
Dodici Apostoli di Costantinopoli, fu consacrata nel 1094.
La
Basilica di San Marco è uno dei più spettacolari luoghi di culto del
mondo, simbolo dell'antica potenza marittima e commerciale della Repubblica
veneziana. Decorata con un incredibile numero di tesori giunti qui come bottino
di guerra, sormontata da cinque cupole a bulbo, sul modello della Chiesa dei
Dodici Apostoli di Costantinopoli, fu consacrata nel 1094.
 La
basilica è famosa per i suoi mosaici dorati, in particolare quelli delle lunette
sotto le arcate della facciata e quelli che decorano le cupole.
La
basilica è famosa per i suoi mosaici dorati, in particolare quelli delle lunette
sotto le arcate della facciata e quelli che decorano le cupole.
L'interno è
rilucente: se riuscite a distogliere lo sguardo dai raffinati mosaici,
soffermatevi sul pavimento in marmo del XII secolo.
Tra i molti tesori
racchiusi nella basilica dietro l'altare maggiore vi è la splendente Pala d'Oro,
in oro, smalto e gemme preziose.
Il Tesoro raccoglie molti oggetti frutto
del bottino ottenuto dal saccheggio di Costantinopoli nel 1204, tra cui una
spina che si dice provenga dalla corona che cinse il capo di Cristo sulla croce.
Sulla loggia sopra il portale principale si trovano le copie delle statue
dei cavalli; gli originali in bronzo dorato, anch'essi sottratti durante il
sacco di Costantinopoli nel 1204, sono in mostra all'interno.
Il Campanile
del X secolo della basilica crollò improvvisamente il 14 luglio 1902, e venne
ricostruito pezzo per pezzo nei 10 anni successivi. Se prendete l'ascensore che
conduce in cima, potete godere di un bel panorama della città e della laguna.
 Palazzo
Ducale - Sulla piazzetta San Marco si affaccia l'elegante Palazzo
Palazzo
Ducale - Sulla piazzetta San Marco si affaccia l'elegante Palazzo
 Ducale, che è stato per secoli il cuore politico della città.
Ducale, che è stato per secoli il cuore politico della città.
In stile
gotico-veneziano, dalle sfumature bianche e rosa, era dimora del Doge e sede
delle più alte magistrature e di un paio di prigioni. Gli appartamenti del Doge
si trovano al primo piano, mentre al secondo piano vi è una successione di sale
di riunione sempre più grandiose, tra cui la Sala delle Quattro Porte
(progettata da Palladio, affrescata da Tiziano e Tintoretto), l'Anticollegio
(con quattro dipinti di Tintoretto e il Ratto di Europa di Veronese), la Sala
del Collegio (ancora opere di Veronese e Tintoretto), per culminare con
l'immensa Sala del Maggior Consiglio (alle pareti il Paradiso di Tintoretto, uno
dei più grandi dipinti a olio del mondo, e l'Apoteosi di Venezia di Veronese).
Una serie di corridoi conduce all'angusto e racchiuso Ponte dei Sospiri, che
collega il palazzo alle Prigioni Nuove. Potete poi uscire dall'ingresso
principale, la gotica Porta della Carta.
 Accademia
- Le Gallerie dell'Accademia ospitano la più importante raccolta di
pittura veneziana, di cui illustra lo sviluppo dal XIV al XVIII secolo. Il
percorso di visita inizia dalla sala riunione della Scuola Grande di Santa Maria
della Carità, la più antica delle Scuole Grandi (le sei maggiori confraternite
di Venezia).
Accademia
- Le Gallerie dell'Accademia ospitano la più importante raccolta di
pittura veneziana, di cui illustra lo sviluppo dal XIV al XVIII secolo. Il
percorso di visita inizia dalla sala riunione della Scuola Grande di Santa Maria
della Carità, la più antica delle Scuole Grandi (le sei maggiori confraternite
di Venezia).
Le opere di maggior interesse qui sono la Madonna col Bambino
di Paolo Veneziano e la pala d'altare Crocifissione e Apoteosi di Carpaccio.
Le sale successive ospitano splendide opere di Giovanni Bellini, in particolare
la sua Madonna col Bambino tra S. Caterina e la Maddalena, e la misteriosa
Tempesta di Giorgione.
Ai dipinti di Tiziano seguono il
 Ritratto di gentiluomo nel suo studio di Lorenzo Lotto, il Convito in casa
Levi di Paolo Veronese, e il Trafugamento del corpo di S. Marco e Crocifissione
di Tintoretto. Proseguendo in senso cronologico, si giunge ai caratteristici
paesaggi di Canaletto e Guardi e alle vedute d'interno di Pietro Longhi. La
visita volge al termine con le vibranti scene di folla del XV secolo del
Miracolo della Vera Croce di Carpaccio e della Processione in San Marco di
Gentile Bellini, che fanno rivivere il passato con la loro meticolosa attenzione
ai dettagli.
Ritratto di gentiluomo nel suo studio di Lorenzo Lotto, il Convito in casa
Levi di Paolo Veronese, e il Trafugamento del corpo di S. Marco e Crocifissione
di Tintoretto. Proseguendo in senso cronologico, si giunge ai caratteristici
paesaggi di Canaletto e Guardi e alle vedute d'interno di Pietro Longhi. La
visita volge al termine con le vibranti scene di folla del XV secolo del
Miracolo della Vera Croce di Carpaccio e della Processione in San Marco di
Gentile Bellini, che fanno rivivere il passato con la loro meticolosa attenzione
ai dettagli.
Ponte di Rialto -
Anticamente il Ponte di Rialto era l'unico collegamento stabile
delle due sponde del Canal Grande.
La leggenda ricorda che nel 1181 Nicolò
Bareteri costruì un ponte di barche chiamata “Quartarolo”, dalla piccola moneta
di pedaggio che si richiedeva per il passaggio. Nel XIII sec. fu sostituito con
un ponte di legno, che venne distrutto durante la rivolta di Bajamonte Tiepolo,
che si ritirò con i rivoltosi presso le  case de Tiepolo e dei Querini presso Rialto. Il ponte fu ricostruito ma
col passare del tempo andò in rovina e finì per crollare nell'anno 1444 per la
gran folla accorsa ad assistere al passaggio della Marchesa d Ferrara.
Ricostruito in legno in forma più ampia, con botteghe, con ponte mobile,
(quadro) all'inizio del ‘500 era così deperito che restaurato dall'arch. Giorgio
Spavento (1501) caduto in parte, si deliberava (1524) di ricostruirlo in pietra.
Presentarono progetti i più famosi architetti del tempo: Michelangelo, Palladio,
Vignola, Sansovino e più tardi Antonio da Ponte, Vincenzo Scamozzi e Alvise
Bandù. Il Da Ponte fu il costruttore (ma solo in parte l'ideatore) con l'aiuto
del nipote Antonio Contin.
case de Tiepolo e dei Querini presso Rialto. Il ponte fu ricostruito ma
col passare del tempo andò in rovina e finì per crollare nell'anno 1444 per la
gran folla accorsa ad assistere al passaggio della Marchesa d Ferrara.
Ricostruito in legno in forma più ampia, con botteghe, con ponte mobile,
(quadro) all'inizio del ‘500 era così deperito che restaurato dall'arch. Giorgio
Spavento (1501) caduto in parte, si deliberava (1524) di ricostruirlo in pietra.
Presentarono progetti i più famosi architetti del tempo: Michelangelo, Palladio,
Vignola, Sansovino e più tardi Antonio da Ponte, Vincenzo Scamozzi e Alvise
Bandù. Il Da Ponte fu il costruttore (ma solo in parte l'ideatore) con l'aiuto
del nipote Antonio Contin.
Il ponte fu costruito tra i 1588-1591 sotto il
dogato di Pasquale Cicogna, l'epitaffio commemorativo sormontato dal suo stemma,
si può scorgere ai quattro lati del ponte. Il ponte di poderosa mole,
solidamente pianta su palafitte, l'unica audace arcata di oltre 28 metri che
sopporta due file di botteghe, collegate tra loro al centro da due grandi archi
che si tripartiscono l'intera larghezza del ponte.
Palazzo Grassi - Antichissima, la famiglia Grassi trasse l'origine da
Bologna, e nel 1230 si trasferì a Chioggia, di cui ottenne la cittadinanza nel
1646.  Trasmigrata
a Venezia salì agli onori del patriziato nel 1718 in un Paolo e fratelli (uno
dei quali per nome Pietro fu vescovo di Parenzo) offrendo alla Repubblica
nell'ultima guerra contro i Turchi 60 mila ducati d'argento. Angelo, figlio di
Paolo, edificò verso la metà del secolo scorso un magnifico palazzo in «Campo S.
Samuele», sulle cui scale, a documento dei propri figli, fece scolpire il motto:
Concordia Res Parvae Crescunt. Palazzo di poderosa struttura, con stilemi
classicheggianti. Dopo un accurato restauro per conto della Fiat diretto da Gae
Aulenti e Antonio Foscari, è divenuto negli ultimi anni contenitore di
importanti mostre.
Trasmigrata
a Venezia salì agli onori del patriziato nel 1718 in un Paolo e fratelli (uno
dei quali per nome Pietro fu vescovo di Parenzo) offrendo alla Repubblica
nell'ultima guerra contro i Turchi 60 mila ducati d'argento. Angelo, figlio di
Paolo, edificò verso la metà del secolo scorso un magnifico palazzo in «Campo S.
Samuele», sulle cui scale, a documento dei propri figli, fece scolpire il motto:
Concordia Res Parvae Crescunt. Palazzo di poderosa struttura, con stilemi
classicheggianti. Dopo un accurato restauro per conto della Fiat diretto da Gae
Aulenti e Antonio Foscari, è divenuto negli ultimi anni contenitore di
importanti mostre.
Chiesa di Santa Maria Formosa - La leggenda
narra che la Beata Vergine apparve in questo luogo al vescovo S. Magno
comandandogli di erigere una chiesa in suo nome. Questa nuova chiesa fu dedicata
alla Purificazione della Beata Vergine, e il popolo la chiamò con il nome di
S.M. Formosa in memoria alle forme prosperose con le quali la Vergine apparì. La
leggenda è sorta nel Trecento e se ne ha documentazione per la prima volta nel
1060.
I "casselleri" (fabbricatori di casse che servivano per le spedizioni
di merci o per contenere il corredo delle spose novelle) avevano la loro scuola
di devozione, sacra a S.
 Giuseppe,
presso la chiesa di S.M. Formosa ,riportando una vittoria nel giorno della
Purificazione di Maria Vergine, chiesero al doge e alla Signoria di recarsi ogni
anno in visita alla chiesa . In occasione di tale visita il doge veniva
omaggiato dal pievano di S.M. Formosa di due cappelli di carta o di paglia
dorata, due fiaschi di malvasia con sopra due aranci : questi doni furono la
conseguenza della risposta assai scherzosa che il doge diede alla loro richiesta
di pellegrinaggio: "E se stesse per piovere? E se avessimo sete?" e i "casselleri"
prontamente gli risposero: "Noi vi daremo cappelli da coprirvi e vi daremo
da bere". La chiesa che diventò subito parrocchiale fu rifatta dopo solo
due secoli per opera dei figli di Marino Patrizio nel 864. Un incendio la
distrusse nel 1105. Le due facciate principali quelle che dà sul campo (1604) e
quella che dà sul canale (1542) furono finanziate dalla famiglia Cappello. La
chiesa subì nel corso del tempo altri restauri: ricordiamo qui quello avvenuto
nel 1842 e quello più consistente avvenuto nel 1916 a causa di una bomba caduta
il 9 agosto di quell'anno.
Giuseppe,
presso la chiesa di S.M. Formosa ,riportando una vittoria nel giorno della
Purificazione di Maria Vergine, chiesero al doge e alla Signoria di recarsi ogni
anno in visita alla chiesa . In occasione di tale visita il doge veniva
omaggiato dal pievano di S.M. Formosa di due cappelli di carta o di paglia
dorata, due fiaschi di malvasia con sopra due aranci : questi doni furono la
conseguenza della risposta assai scherzosa che il doge diede alla loro richiesta
di pellegrinaggio: "E se stesse per piovere? E se avessimo sete?" e i "casselleri"
prontamente gli risposero: "Noi vi daremo cappelli da coprirvi e vi daremo
da bere". La chiesa che diventò subito parrocchiale fu rifatta dopo solo
due secoli per opera dei figli di Marino Patrizio nel 864. Un incendio la
distrusse nel 1105. Le due facciate principali quelle che dà sul campo (1604) e
quella che dà sul canale (1542) furono finanziate dalla famiglia Cappello. La
chiesa subì nel corso del tempo altri restauri: ricordiamo qui quello avvenuto
nel 1842 e quello più consistente avvenuto nel 1916 a causa di una bomba caduta
il 9 agosto di quell'anno.
Scuola di San Marco
- La Scuola Grande di San Marco è una delle più armoniose e significative opere
architettoniche del Rinascimento veneziano . La scuola 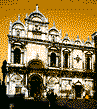 è
detta anche “dei battuti” ed è una delle sei scuole grandi di Venezia. Sorta nel
1260 con scopi religiosi ed umanitari, ebbe sempre una particolare protezione da
parte della Signoria. Molti dei confratelli di questa scuola furono uomini di
gran fama e censo. Incendiata e quasi distrutta nel 1485 venne ricostruita sotto
la direzione di Pietro Lombardo. Nel 1490 la direzione dei lavori per la
facciata e lo scalone interno furono assegnati all'architetto Mauro Codussi e
vennero ultimati nel 1495. Per la bellezza delle opere d'arte che racchiudeva e
per la magnifica architettura rinascimentale con la quale era stata costruita,
era la più bella fra le Scuole Grandi. Nel 1815 gli Austriaci la modificarono,
demolendo parte dell'interno, e trasformando l'edificio in un ospedale. La
Scuola oggi coincide con l'ingresso principale dell'Ospedale Civile di Venezia.
è
detta anche “dei battuti” ed è una delle sei scuole grandi di Venezia. Sorta nel
1260 con scopi religiosi ed umanitari, ebbe sempre una particolare protezione da
parte della Signoria. Molti dei confratelli di questa scuola furono uomini di
gran fama e censo. Incendiata e quasi distrutta nel 1485 venne ricostruita sotto
la direzione di Pietro Lombardo. Nel 1490 la direzione dei lavori per la
facciata e lo scalone interno furono assegnati all'architetto Mauro Codussi e
vennero ultimati nel 1495. Per la bellezza delle opere d'arte che racchiudeva e
per la magnifica architettura rinascimentale con la quale era stata costruita,
era la più bella fra le Scuole Grandi. Nel 1815 gli Austriaci la modificarono,
demolendo parte dell'interno, e trasformando l'edificio in un ospedale. La
Scuola oggi coincide con l'ingresso principale dell'Ospedale Civile di Venezia.
![]() Musei e pinacoteche a
Venezia
Musei e pinacoteche a
Venezia